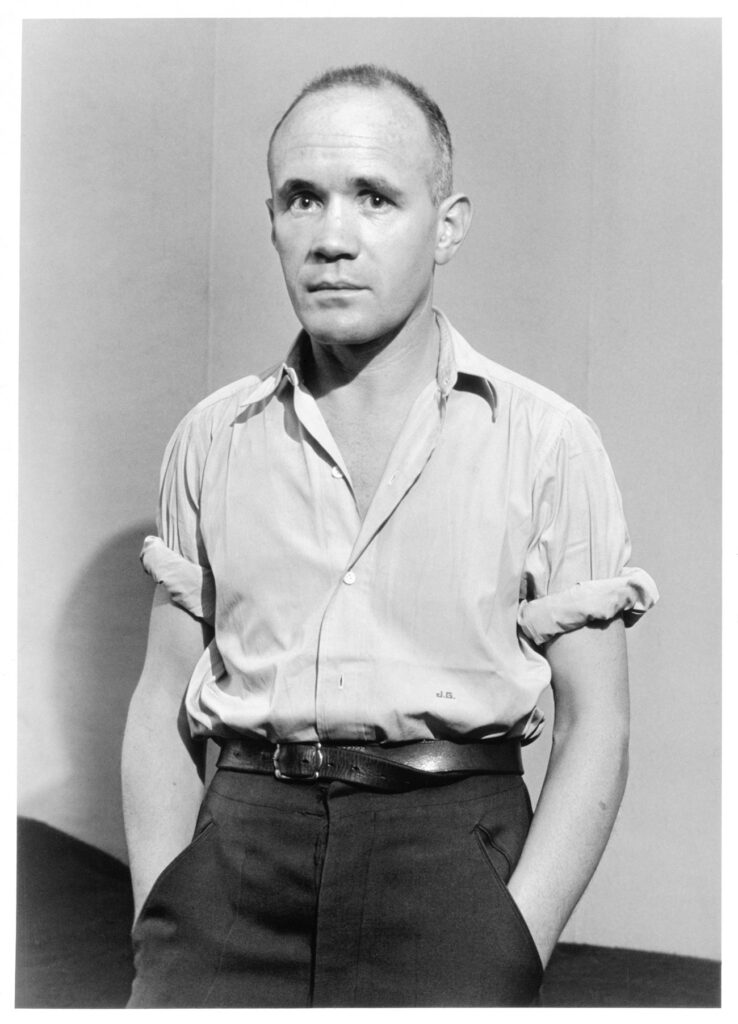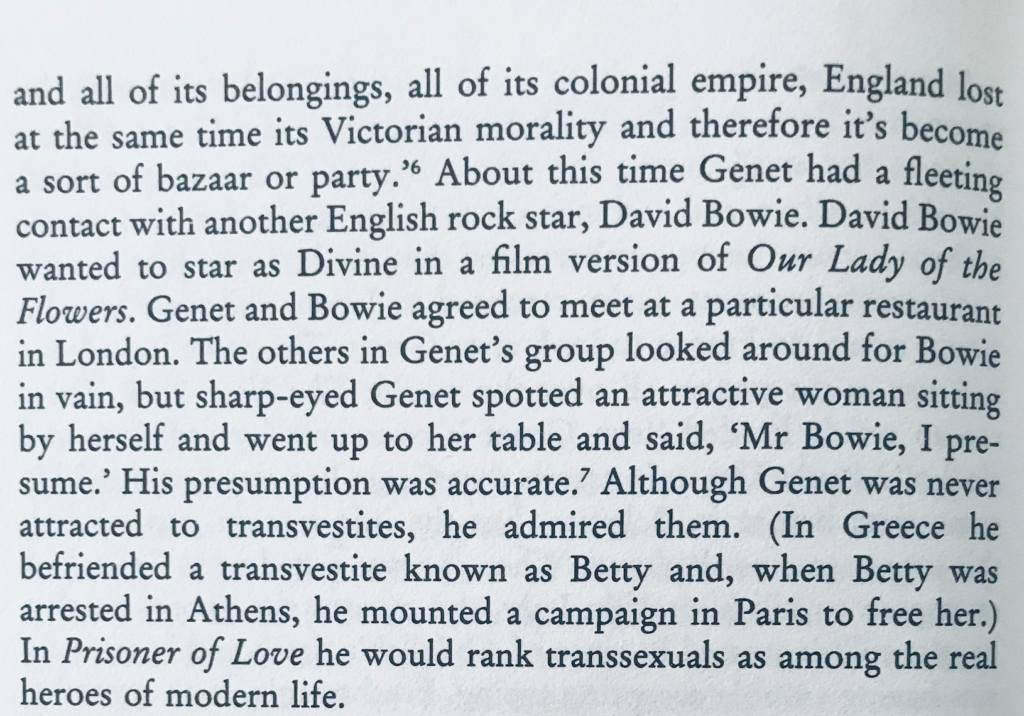Ma perché?

Per festeggiare l’ennesimo giorno di coprifuoco, l’altra notte l’insonnia mi ha regalato il brivido di assistere in diretta all’arrivo dell’ora solare. Seduto in poltrona, gli occhi sbarrati e provvisoriamente sazi dalle precedenti tre ore di sonno, il corpo galleggiante nell’ovatta ovunque, la sensazione di potere che devono provare gli apparecchi elettronici quando, arrivati all’1%, sono rianimati da una batteria d’emergenza (ma è solo un fuoco di paglia, non dura, non durerà, la notte è lunga, troppe app, troppo cervello, troppo surriscaldamento) pensavo al fatto che in Francia l’ora legale e l’ora solare le chiamiamo heure d’été e heure d’hiver e mi chiedevo: “Ma perché?” (“E l’autunno? E la primavera?”) (“Si tratta di praticità? Di poesia? Di sciatteria?”). In mezzo a tutta questa perplessità, ma ormai ovviamente non stavo più pensando al cambio dell’ora, ho alzato la serranda e ho guardato fuori dalla finestra.
Come nel finale di quel film di Haneke in cui non si capisce se qualcuno abbia messo pausa o sia solo un altro mezzo di tortura psicologica inflitto a chi sta guardando, tutto era fermo. Sembrava che persino l’apocalisse stesse trattenendo il respiro, per verificare fin dove arrivare prima di arrendersi. Troppa stasi, troppa differita, troppo aspettare non si sa bene cosa, anzi no, una cosa che si muoveva c’era: una bicicletta, una di quelle a noleggio, era appoggiata senza garbo a una ringhiera, e il fanalino posteriore rosso lampeggiava senza sosta, avevo l’impressione di sentirne il battito anche a distanza: tic tac, tic tac, tic tac (“Ma perché lampeggia?”) (“Già, perché?”).
Mancava poco. Ho preso dalla tasca il telefono e ho aspettato il momento in cui sarebbero state le tre e poi le due, di nuovo. Il cuore mi batteva forte. Ho temuto che niente sarebbe più stato all’altezza di questa specie di trucco magico. Ho pensato a una mia amica, il giorno prima l’avevo chiamata perché avevo letto il titolo di un giornale (“Un’ora in più per dormire, un’ora in più per il coprifuoco”), e volevo lamentarmi con lei, chiederle “Perché improvvisamente tutti mi sembrano così cretini?”, ma lei mi aveva anticipato dicendo “Sai, mio marito è un cretino”.

Il mio problema con l’insonnia non è l’insonnia in sé, ma neanche in me, in te, in loro, in quelli che dicono: “Mi raccomando, stasera però cerca di dormire” (mio padre); “Hai provato con quella valeriana che ti ho messo l’anno scorso nel pacco da giù?” (mia madre); “Apri whatsapp, ti mando subito il contatto del mio nuovo spacciatore” (chi mi vuole davvero bene); “Signor Morabito”, pausa di compassione, mezzo sorriso, “per oggi la seduta è finita” (la mia ex-analista); “l’insonnia è bellissima, finalmente posso dedicarmi a me stessa” (persone mitomani a caso). No, il mio vero problema con l’insonnia è l’attimo in cui metti un piede nell’interstizio, e inizi a fluttuare, fluttuare, e provi ad aggrapparti a qualsiasi cosa (Malamud; Mia Ceran; Tom Mercier; i cereali mangiati direttamente dalla scatola) ma tutto scappa di mano, si sfarina, cede, non esiste: ciò che all’inizio era dolce assenza di gravità a poco a poco si trasforma in qualcos’altro, lo spazio si restringe il nero si allaga, come nel finale dei vecchi cartoni quando una specie di dissolvenza a monocolo lasciava solo un cerchietto con il protagonista e partiva la buffa musichetta, solo che questo non è un cartone e non c’è niente da ridere.
All’alba ho modificato manualmente l’orario del forno perdendo un po’ più di tempo del necessario perché mi sono messo a pensare che forse dovrei comprarmi delle ciabatte invernali, o forse no, poi ho iniziato a leggere l’edizione digitale di Libération dedicata alla gauche francese e all’Islam, alle divisioni interne alla gauche francese, ho annuito nel vuoto leggendo delle cose, mi sono innervosito leggendone altre, ho pensato a Samuel Paty, il professore decapitato, mi sono ritrovato in un vicolo cieco come ormai troppo spesso mi capita quando cerco di collocarmi politicamente, ho ripensato a quello che dicevo giorni prima a un’altra mia amica, sai non riesco più a entrare in un cinema, non ce la faccio, entro fine mese decido se disdire la tessera Ugc, ho pensato a una scena dell’ultimo film di Sorkin che sembrava scritta da Robert e Michelle King, e ho sorriso, quelli bravi io me li immagino che si divertono sempre.
Mi sono vestito pesante, ho messo una sciarpa di lana intorno al collo, ho preso l’ombrello, e sono uscito. Fuori pioveva in diagonale, le raffiche di vento freddo sollevavano le foglie esauste facendole roteare inutilmente prima di ributtarle per terra a schiaffi. Camminavo sul viale, e mi sentivo la faccia tagliata in due, una e due. All’incrocio con rue Cambronne una fila di taxi vuoti sonnecchiava in attesa di clienti, rivoli di pioggia mista a fango colavano sotto i marciapiedi, il fioraio dell’angolo ne approfittava per buttare secchiate di acqua lorda. Mentre attraversavo la strada per andare in boulangerie ho incrociato un tizio con i capelli lunghi ossigenati, una specie di versione adulta e ancora più irregolare del ragazzino di We are who we are. Indossava dei boxer da mare di color verde con tanti piccoli ananas stampati, una camicia hawaiana a fiori e un paio di infradito con cui sembrava pattinare sull’acqua, quale pioggia, quale freddo, quale cosce di fuori, quale preoccupazioni. Mi sono chiesto se vedesse in me la versione speculare dell’alieno che avevo di fronte, un’ apparizione resa concreta dall’unico dettaglio fuori posto, una mascherina slabbrata appesa al mento, gocciolante di pioggia. Ma poi l’ho superato, sono entrato in boulangerie e ho comprato i cornetti. Mi sono infastidito, perché la busta era troppo piccola e i cornetti sbucavano da sopra, si stavano già ammosciando. Tornando verso casa ho cercato il punto esatto del marciapiede sotto la mia finestra. La bicicletta era ancora appoggiata senza garbo alla ringhiera. Mi sono avvicinato per guardare il fanalino posteriore rosso: mi sembrava che lampeggiasse più debolmente, forse si sta scaricando, ho pensato, o forse è solo che di notte ogni cosa è più nitida, specialmente i fanalini che lampeggiano senza sosta e non sai perché.